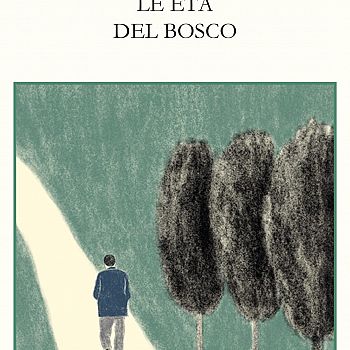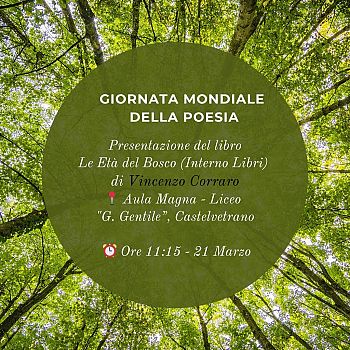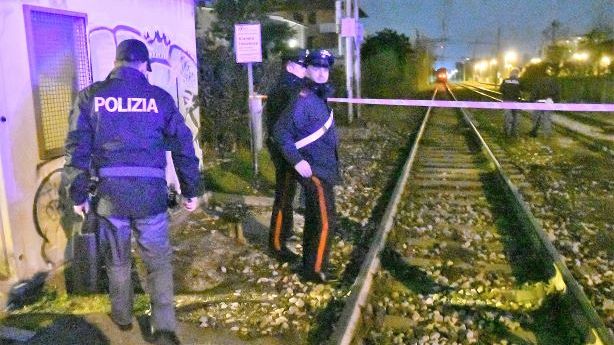Le età del bosco di Vincenzo Corraro è una raccolta poetica che esplora il rapporto tra memoria, tempo e natura attraverso una scrittura evocativa e meditativa. Strutturata in due sezioni, la silloge è un viaggio lirico in cui il paesaggio boschivo diventa specchio di un’indagine interiore. Il titolo suggerisce una stratificazione temporale: il bosco è testimone delle stagioni che passano, proprio come l’essere umano attraversa diverse fasi della vita. Corraro costruisce un itinerario poetico che avvolge il lettore in una spirale di parole e sensazioni, coinvolgendolo in un dialogo tra visibile e invisibile, tra umano e non umano. Il suo è un linguaggio ricco, sensoriale, che cerca di ricomporre una realtà frammentata e distante, offrendo uno sguardo nostalgico ma anche meravigliato sul mondo e sulla propria interiorità.
Uno dei cardini della raccolta è il tempo, legato strettamente alla memoria. Corraro scrive versi che nascono dal desiderio di trattenere attimi, di fissare l’effimero per farlo diventare esperienza duratura. La poesia diventa così uno strumento per riannodare il passato, restituendo frammenti di vita, incontri, sensazioni sospese tra l’intimo e il collettivo. L’idea che il ricordo possa essere una forma di resistenza all’oblio attraversa tutta la raccolta: il poeta torna ai luoghi della giovinezza, rievoca volti e momenti, consapevole che solo la parola può dare loro un’esistenza duratura.
Un altro tema centrale è la natura, che non è mai un semplice sfondo, ma un vero e proprio organismo vivo. Il bosco, con il suo respiro antico, diventa un luogo di rivelazione e raccoglimento, un rifugio in cui l’io lirico si misura con il mistero del tempo e dell’esistenza. Alberi, foglie, animali, stagioni: ogni elemento naturale assume una valenza simbolica, suggerendo che l’uomo e il mondo vegetale condividano un destino comune. La poesia diventa così un esercizio di ascolto della natura, un modo per restituirle voce e significato. In questa dimensione, emerge un senso di sacralità panica, dove il paesaggio si fa eco di interrogativi profondi, quasi metafisici.
All’interno di questo scenario, si sviluppa anche una riflessione sull’esistenza e sul senso dello stare al mondo. La poesia di Corraro si muove tra la consapevolezza della precarietà e la ricerca di un riparo, tra il desiderio di stabilità e la percezione del continuo fluire delle cose. La solitudine e la distanza, che emergono in diversi testi, non sono mai del tutto negative: diventano piuttosto spazi di riflessione, occasioni per cogliere il valore di ogni attimo e di ogni incontro. Il poeta sembra suggerire che l’unico antidoto alla caducità sia la meraviglia, ovvero la capacità di stupirsi delle piccole cose, di riconoscere la bellezza nei dettagli, nei gesti quotidiani, nel silenzio della natura.
Lo stile di Corraro è caratterizzato da una ricerca accurata della parola, sempre misurata e ricca di risonanze. Pur essendo sorvegliato, il suo linguaggio non risulta mai artificioso: al contrario, riesce a fondere la precisione espressiva con una grande capacità evocativa. L’uso del verso libero e delle pause conferisce ai testi un ritmo naturale e riflessivo, creando una tensione tra il detto e il non detto. Spesso i versi si dispiegano in lunghe sequenze, con un andamento che ricorda la prosa poetica, ma senza mai perdere la musicalità.
Dal punto di vista delle immagini, la poesia di Le età del bosco si nutre di elementi concreti e sensoriali: il lettore si trova immerso in paesaggi di foglie, vento, acque inquiete, cieli mutevoli. La natura non è solo un luogo fisico, ma una dimensione dello spirito, un terreno in cui si intrecciano memoria e presente. Il poeta riesce a creare un tessuto simbolico denso e stratificato, in cui ogni elemento acquista un valore universale. L’uso delle anafore, delle allitterazioni e delle rime interne conferisce ai testi una musicalità sottile, quasi ipnotica, che accompagna il lettore in un viaggio tra il reale e l’onirico.
Il tono della raccolta è prevalentemente elegiaco, con momenti di intensa riflessione sul senso del tempo e della perdita. Tuttavia, non manca una vena contemplativa, che restituisce alla parola poetica una funzione quasi sacra, come se il poeta cercasse un contatto con l’essenza profonda delle cose. In questo, la sua scrittura si avvicina alla tradizione della poesia lirica e meditativa, pur mantenendo una forte originalità.
Le età del bosco si inserisce in una tradizione letteraria che dialoga con grandi autori del passato e del presente. Si possono cogliere echi di Giovanni Pascoli, nella sua attenzione alla natura come luogo di segreti e rivelazioni, e di Cesare Pavese, per la capacità di raccontare il legame tra uomo e paesaggio in una dimensione mitica. Il senso di nostalgia e di radicamento nei luoghi dell’infanzia richiama anche la poetica di Federigo Tozzi, di cui Corraro cita un passo in apertura del libro.
Sul versante contemporaneo, si possono trovare affinità con la voce di Mariangela Gualtieri, nella sua ricerca di una parola capace di farsi preghiera e riflessione sull’essere. In alcuni passaggi, emerge anche una tensione filosofica che richiama il pensiero di Simone Weil, segno che la poesia di Corraro non è solo contemplazione, ma anche interrogazione sulla condizione umana.
A livello tematico, il libro si avvicina a quelle opere che esplorano il rapporto tra memoria e natura, tra finito e infinito, tra presenza e assenza. Il bosco, in questo senso, diventa il simbolo di una realtà che sfugge, ma che al tempo stesso conserva le tracce di ciò che è stato. Corraro riesce a costruire una poesia che ha radici profonde nella tradizione, ma che al tempo stesso si rivela estremamente attuale nella sua capacità di restituire il senso dello smarrimento contemporaneo.
Bia Cusumano