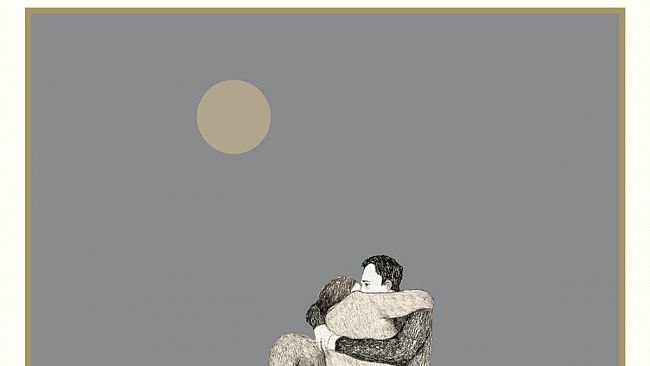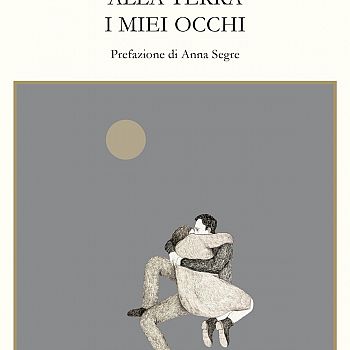Ci sono poeti di cui t’innamori subito. Appena sfiori il loro libro, appena tocchi i loro versi. Appena inciampi e ti ferisci tra le loro parole. Ci sono poeti come Mauro Liggi che ti permettono ancora di fremere di bellezza intesa come liberazione da colpe mai commesse. Mauro, anima di vetro. Lo attraversi con lo sguardo da parte a parte. Non ha paura di farsi pasto. Di donarsi per nutrire. Di farsi benda per avvolgere le ferite. Di farsi poesia come medicamento. Ma ci sono farmaci più efficaci.
Ci sono cure più potenti e Mauro che nella vita d’ogni giorno di mestiere fa il medico, pur se ha studiato su manuali imponenti, lo sa. Anima di vetro e figlio di un Dio distratto. Esile, viso scarno, occhiali tondi inforcati con delicatezza sul naso. Un giovane uomo alla ricerca di una vista più profonda. Nudo sotto il camice bianco. Ché non è vero che la poesia è finzione. E’ così vera che fa tremare la carne. Mauro, nella sua ultima silloge, Alla terra i miei occhi, edita da Interno Versi non fa sconti a nessuno.
Né all’amore, né alla morte, né a quello che sopravvive oltre, né alla passione che trasuda, né al dolore del lutto che fende e deturpa. Non fa sconti nemmeno a Dio. In una poesia della silloge, addita questo Dio distratto, con un parlare nitido, senza reticenze ed ossequi. E’ un dialogo alla pari, intessuto come quello di due amici che non hanno chiuso mai i conti o due nemici che pur con acredine, cercano di stipulare una pace. Pace precaria tra debiti e crediti in una partita dissacrante.
E sarà Dio a dover chiedere scusa al poeta per quello che gli ha negato, all’uomo per quello che gli ha proibito di vivere, al figlio che forse non ha guardato con compassionevole occhio di Padre mentre era intento a giocare con le cascate. Mauro riesce a raccontare la morte con candore. La morte di chi troppo presto t’ha lasciato solo nel mondo. Troppo presto si è consunto tra lenzuola e federe, tra farmaci e ricordi di girotondi spensierati, ben presto divenuti sudari.
Mauro sembra cercare un modo dolce e suadente che possa funzionare, come un protocollo che guarisce, per raccontare la vita. Sì, lui cerca il modo per lasciare andare il dolore, per perdonare lo strappo, per perdonare la morte che dissacra, che deturpa, che defrauda, che dona illusioni d’ evasione. Ma “era solo vita, non un processo”, lo chiosa alla fine di un’altra poesia. Bisogna dunque cercare di perdonare gli errori, l’amore dato che non sarà mai abbastanza, le colpe commesse, le imperfezioni e le fragilità.
Anche in questo caso, Mauro cerca una via, una soluzione da uomo, forse da medico. Ma da poeta sa bene che è la ragione ad esigere la composizione delle parti per salvarsi, l’assoluzione per mettere a posto i pezzi ma la poesia vive di sbilanciamenti, di tensioni, di strappi, di bilico e trapasso, di fenditure e punti a croce. La poesia fa piovere sangue. “Conficca lame in distese di papaveri”. La poesia fa baciare i petali di ogni morte. Propria o altrui, fa lo stesso.
Mauro adesso è il padre che legge il quotidiano, la madre che sferruzza i ferri da maglia, l’amata che conosce i segreti più intimi, i pazienti delle corsie d’ospedale, i cieli neri e indigesti. Mauro è una preghiera sommessa che chiede pace tra le tempeste: “solo uno squarcio di luce, solo, vi prego, un domani qualsiasi.” Perché sarà stato quel Dio distratto convocato alla resa dei conti, a noi lettori non è dato saperlo con precisione e qui alita il segreto indicibile della poesia, “gli hanno rubato l’alba, saccheggiato il mattino, scassinato il tempo.” E’ la storia dell’uomo moderno, dell’uomo antico, di ogni uomo di ogni tempo.
La Poesia è l’unica possibilità, l’unica scelta inamovibile, irrinunciabile. Chi potrebbe risarcirci di quanto abbiamo perso? Forse quel Dio distratto? Forse gli altri uomini? Forse l’amore che pur pulsa a fiotti tra le pagine della silloge? Ma quale amore? Quello ancestrale e ombelicale che lega la madre ai figli o l’amore sensuale dei baci tra “labbra strette tra denti”? Tutti i volti dell’amore sono cantati in questa silloge delicata e potente, dolente e pensosa, profonda, viscerale e lucida.
Eppure resta una invocazione tra le mani che sanno attraversare incaute e spudorate i versi di Mauro, una sottile invocazione. La consegno ai lettori perché Mauro la consegna a sé stesso prima di tutti, come un testamento e un manifesto poetico. Ma, in questo è il gioco fine dell’intellettuale che ben conosce l’arte, ce lo avesse detto all’inizio, ad apertura di silloge, tutto sarebbe stato più semplice e agevole. Il viaggio sarebbe andato spedito verso la sua meta. Ma il testamento è l’ultima invocazione da vivo da consegnare ai posteri, ai sopravvissuti, ai lettori accorti che si sono guadagnati la fiducia del poeta e con cui il poeta ha intessuto un dialogo muto e autentico.
L’ultima poesia dunque ci restituisce il senso intimo dell’intera silloge ma non l’approdo. Perché i poeti se avessero approdo non sarebbero poeti ma scienziati.
“Scavo con le palpebre
nella terra umida
sciolgo il perdono.
Allatto un germoglio
di pianto
Le mani a coppa.
Calati pure tu
sotterra ora
anche ciò
che è vita.
la mia inquietudine
vuole farsi albero.
Alla terra i miei occhi.”
Ecco dunque ciò che Mauro ci consegna: scavare con le palpebre, sciogliere il perdono, allattare germogli, sotterrare la vita, mutare forma all’inquietudine ché se diventa albero ha radici, ha terra, ha possibilità di rinascita, ha speranza di germogliare, fiorire, trovare benedizione, forse perdono. E in quella chiusa finale “Alla terra i miei occhi” vi è una consapevole fusione panica. Vi è liberazione dalle forme che ingabbiano, dai patimenti umani, così umani da non trovare pace, conforto, tregua.
Oh, magari Mauro, fossimo terra adesso. Terra che germoglia, che rinasce, che riplasma, che mette radici, che non sente vergogna, colpa o peccato. Ma forse poeta, ci hai sussurrato senza arroganza e saccenteria il modo. La poesia non è terra che muta? Non è terra che nutre? Non è l’unica terra per i poeti in cui essere tutto e tutti, sentire ogni cosa fortemente e con delicatezza? Fossimo terra, Mauro, muteremmo le nostre inquietudini in alberi, certi che Dio forse, possa essere meno distratto.
Certi che neanche ci chiederemmo se esista un Dio a cui chiedere il conto. Fossimo terra, adesso Mauro, saremmo rinati dalla morte come ogni stagione sa fare. Non esisterebbe fine, né amore che divide o strazia, né attesa, né sopruso, né malinconia, né paura, né solitudine. Saremmo salvi ma non saremmo più uomini e non poeti. Allora, per benedire questa nostra condizione, nonostante tutto il dolore, Mauro chi ha fatto circumnavigare tutte le sfumature, tutti gli odori, i sapori, i rivoli, i silenzi, le parole, i paesaggi, le emozioni, i colori, le pieghe.
Non siamo stati soli però. Mauro ci ha tenuto per mano, ci ha sostenuto il cuore, ci ha sospinto il passo. Alla fine e solo alla fine, ha dovuto pur farci prendere il largo in un viaggio che pare approdare alla terra invece se capovolgiamo lo sguardo, la vista e gli occhi, se compiamo il salto, arditi, ci apre all’immensità dell’essenziale. Così ancorati a testa in giù, non ci resta che un’unica visione: il cielo che s’apre. La verità nuda. La Poesia che abbraccia e accoglie. Quel Dio distratto che accarezza un’anima di vetro.
Le anime di vetro di noi tutti.